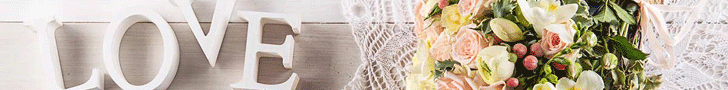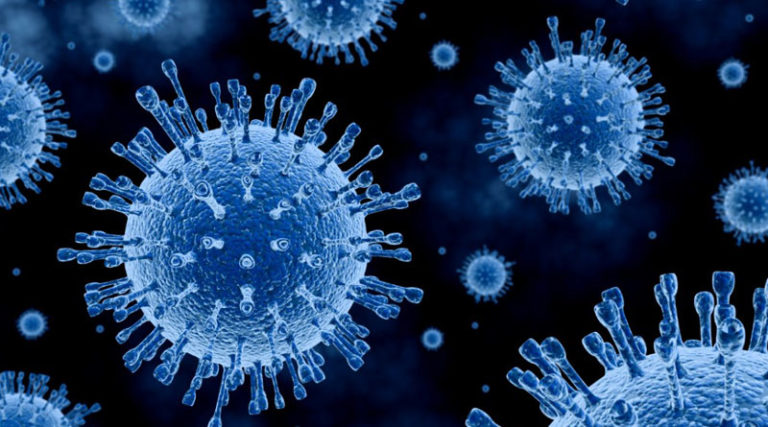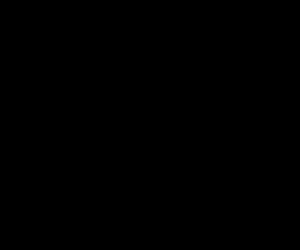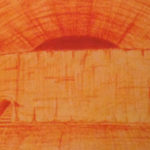TRATTO DAL LIBRO “SETTIMANA SANTA” – Edito Foto Belviso
Alle ore 22.00, a volte avvolta dall’ ebbrezza primaverile e a volte da un freddo rigido, ultimi colpi di coda di una stagione invernale che si sta allontanando, esce dalla Chiesa del Purgatorio la processione di Cristo Morto, seguito dal simulacro della Madonna Addolorata.
Il rito è officiato dall’ Arciconfraternita della Morte e Orazione, comunemente detta del Purgatorio.
L’ antica chiesa dei Gesuiti, sin dal Giovedì Santo, era meta di un mesto e continuo pellegrinaggio di popolo che visitava la camera ardente allestita nel presbiterio, quando si officiava l’ ora del Getsemani, con i fedeli che vegliavano spiritualmente con Gesù, in quell’ orto, in attesa del tradimento di Giuda e dell’ inizio della sua passione e morte.
Attualmente la Chiesa viene aperta e i simulacri posti alla venerazione dei devoti, solo nel primo pomeriggio del Venerdì Santo, dopo la morte di Gesù che la liturgia fa risalire alle tre del pomeriggio.
Il Cristo, di epoca settecentesca, è disteso su un materassino bianco ricamato e poggia il capo su un cuscino dello stesso colore dal quale pendono quattro fiocchetti dorati ed è posto in una bara al centro dell’ area presbiteriale, davanti all’ altare maggiore.
Vi sono due bare, la prima di legno e cristallo con cornice dorata, di scuola napoletana, donata all’ Arciconfraternita da Isidoro Dalò, congregato dello stesso sodalizio, grande benefattore che donò alla chiesa altre statue e arredi sacri; la seconda completamente di cristallo donata nel 1959 dai coniugi Espedito Buonsanti e Natalia Labia.
Alla destra della bara, il simulacro della Madonna Addolorata, del tipo manichino con gabbia, con abito e velo nero merlettato, con un cuore trafitto da una spada dorata e in mano un fazzoletto bianco merlettato.
L’ espressione è settecentesca, con reminiscenza secentesca propria del “manierismo devoto”.
Il Cristo veniva vegliato tutta la notte da giovani e anziani che partecipavano così intensamente al dolore di una madre straziata e affranta per la morte del Figlio.
E a tarda sera, la piazzetta su cui si affaccia la antica e storica Chiesa del Purgatorio, pullula di gente infreddolita e silenziosa. Da ogni casa, mamma, papà, figli, nonni, zii sono venuti sin qui tenendosi per mano, quasi che sia stato operato un miracolo nel richiamo del sangue, nella rigenerazione dell’ amore.
La bara, affiancata da donne con abito nero e con fiaccole, esce dalla chiesa “nazzicando” – movimento tipico delle processioni della Settimana Santa in uso in tutte le regioni dell’ Italia Meridionale – tra le note della banda cittadina che nel silenzio profondo della notte intona:
“Gesù mio, con dure funi, come reo chi Ti legò?
Sono stato io l’ ingrato, Gesù mio perdon pietà.
Gesù mio, la bella faccia, chi crudel Ti schiaffeggiò?
Gesù mio, di fango e sputi, quel bel volto chi T’ imbrattò?
Gesù mio, la nobil fronte, chi di spine ti coronò?
Gesù mio, le mani e i piedi, chi alla Croce te li inchiodò?
.
Il silenzio che domina la folla è interrotto dalle orazioni. La commozione è resa più viva dal rullio cadenzato dei tamburi, che imprimono il ritmo alla folla muta che segue il feretro. Nell’ aria triste rimbombano le note del “Miserere” e del canto:
“O fieri flagelli, che al mio buon Signore, le carni squarciate con tanto dolor. Non date più pene, al caro mio bene, non più tormentate l’ amato Gesù. Ferite, ferite, ferite quest’ alma, che causa ne fu”.
I versi furono scritti da S. Alfonso de’ Liguori, ispirato dall’ amore per Gesù crocifisso. Nell’ inno, il Santo invoca i flagelli, le spine, a non più ferire Cristo ma la sua anima che causa ne fu.
Tra la folla che sosta sui marciapiedi un bimbo allunga la mano per lanciare un bacio, una donna asciuga una lacrima, un vecchio si scopre il capo, un uomo si batte il petto.
Le immagini anche anticamente erano portate in processione secondo la disposizione attuale. Il rito, più che un atto penitenziale, era considerato un vero e proprio funerale: infatti i paramenti del clero erano neri e la Madonna Addolorata seguiva il feretro del proprio Figlio, come in una qualsiasi celebrazione funebre.
Alla processione partecipavano anticamente la Confraternita di S. giuseppe, di S. Rocco e Maria SS. del Rosario e l’ Arciconfraternita dell’ Assunta. Da quando la Chiesa del Purgatorio passò sotto la giurisdizione territoriale della Parrocchia del Carmine, partecipa la Congregazione e l’ intera comunità Carmelitana.
La bara, anticamente era portata a spalle da devoti in abito scuro, affiancata da giovani universitari con il caratteristico berretto a punta, da confratelli con lampieri e da carabinieri in alta uniforme.
Davanti alla bara il Cristo Rosso e il Padre Spirituale, per tanti anni don Luigi Tattoli. Precede la Madonna ancora un altro Cristo Rosso e poi ancora la banda e tanta folla commossa e silenziosa.
Dal 1992 invece, la processione ha assunto un aspetto ancora più caratteristico e suggestivo, con tutti i portantini dei due simulacri che indossano una tunica e cappuccio violaceo e una ruvida fune in vita: auspice don Saverio Del Vecchio, Padre Spirituale della Confraternita. I confratelli procedono incappucciati.
In questo stesso anno si decise di usare, ad anni alterni, la vecchia e la nuova bara.
Il feretro avanza lentamente attraversando piazza Castello, via Mascagni, vico III Assunta, via Tripoli Italiana, via Umberto Giordano, piazza Zingarelli, via don Minzoni, viale Roosvelt, corso Garibaldi, via Curiel, piazza Duomo, corso Garibaldi e corso Gramsci.
Lo segue, ammantata di nero, il cuore trafitto da una spada d’ argento, la donna che Gli fu Madre.
Tempo or sono la processione rientrava quando l’ orologio diffondeva i tocchi delle prime ore del sabato e la gente tornava a casa, andando per le cento vie del paese, tacendo nell’ aspettare l’ alba.
Ad una ad una si spegnevano le luci. La meditazione della morte aveva recitato gli ultimi grani sul rosario del pentimento.
Buona notte augurava la vecchietta, chiudendo la porta di casa. Santa notte le rispondeva l’ ultimo anziano passante, che si affrettava a rincasare.
Tempi or sono, il Venerdì Santo era considerato da tutta la popolazione come il giorno di digiuno e astinenza per eccellenza. Era l’ apice della settimana di penitenza e di tutta la Quaresima, periodo di preparazione alla Santa Pasqua.
Non si mangiavano carne e derivati e addirittura si legavano i cani per impedire loro di mangiarne.
La donna non doveva compiere le faccende domestiche e non doveva curare il proprio aspetto, rifacendosi ad una leggenda popolare che vuole la Madonna aver rivolto la frase: “maledett la trezze ca de venerdije s’ intrezze” ad una donna che alla sua domanda, se avesse visto il Figlio, rispose incurante di no mentre si pettinava. Incontrando un’ altra donna che stava impastando il pane, le rivolse la stessa domanda e questa volta la brava massaia le indicò la strada dolorosa e la Vergine disse: “benedett ‘ù pein ca de venerdije s’ impeine!”.